‘A ricetta ‘e Napule

Scrive Ippolito Cavalcanti nella prima edizione (1837) della sua “Cucina teorico – pratica”:
«Amico mio, teccote la Cucina Casarinola, che t’aggio mprommettuta, corta, corta, ma nce sta tutto lo sentiemento. E si veramente vuò campà nauto secolo e miezo, de cheste vivanne t’haje da servì, pecchè
so senza mbroglie, e t’acconciano lu stommaco. Te prego a compatireme si no la trovarraje scritta comme se convene, pecchè la capo mia ha fatto seccia , e chiù no nce sta; e aggio scritta sta cucina casarinola
chiù pe devertirete e darete piacere, ca pe auto; e pò comme vuò parlà comme se deve trattanno na materia che no può ascì da li tiermene che so necessarie pe te fa capì? E mannaggia no tentillo jonnolillo
d’amico mio, che pe forza ha voluto ch’avesse scritta sta Cucina, nfrascannola co la Cucina pratteca c’haggio scritta nnante a lengua toscana. Ora vide no poco che mmesca francesca: vasta è fatto mo; a
chelle che riesce. Cuvernate, e statte buono.»
Non si può scindere il racconto di Napoli dalla sua cucina.
Una cucina, le cui radici storiche risalgono al periodo greco-romano, che, nel corso dei secoli successivi, si è arricchita attraverso l’influsso delle tante corti dinastiche susseguitesi al governo della città e del territorio circostante; che esprime una separazione ben definita tra una prettamente aristocratica, caratterizzata da piatti elaborati e di ispirazione internazionale, ed una popolare strettamente legata agli ingredienti del territorio.
Per comprendere la cucina napoletana dobbiamo ripercorrere la linea del tempo fino al XVIII secolo, un’epoca durante la quale si iniziò a diffondere la cultura gastronomica, anticipando mode e costumi che sono poi arrivati ai nostri giorni.
Dall’antichità, la cucina napoletana si è sempre caratterizzata per la sua sterminata varietà di piatti sia a base di pesce, uno degli ingredienti più utilizzati nei piatti tipici partenopei, sia di carne, verdure e legumi, non tralasciando antipasti e dolci.
Gradualmente, nel corso dei secoli, grazie a materie prime di ottima qualità:
– lavorazioni del latte, come la mozzarella di bufala, il fior di latte e la provola fresca affumicata;
– pasta artigianale;
– uno straordinario corredo di ortaggi, come i pomodorini vesuviani, i friarielli, la scarola, le zucchine, i peperoni, le melanzane;
– frutta locale;
– prodotti ittici di grande qualità, come i crostacei, i molluschi, il pesce azzurro;
– carne e insaccati (dalle salsicce ai salumi),
la cucina napoletana è riuscita a mescolare, elaborando, pietanze di città e piatti di campagna, lavorando su antiche ricette e adattandosi alla nuove esigenze.
La tradizione culinaria greca annoverare diversi piatti a base di molluschi e pesci, come è raffigurato sugli affreschi delle rovine della vecchia Pompei.
La cultura romana rivoluzionò le portate, introducendo il Garum (una salsa di interiora di pesce) e la colatura di alici tipica di Cetara, i condimenti salati e l’uva passa.
Forse in questo periodo iniziarono i primi esperimenti di pizza con le scarole.
Probabilmente anche l’utilizzo del grano per la pastiera e gli struffoli di Natale prendono origine dai culti pagani.
La leggendaria villa di Lucullo, che nel I secolo a.C. si estendeva dalle pendici di monte Echia sino all’isolotto di Megaride (oggi Borgo Marinari), era la massima espressione del fasto culinario.
Vi erano vivai di pesci prelibati, venivano allevati animali e volatili e, per la prima volta in Europa, furono piantati, importati dalla Persia, il pesco e il ciliegio.
Si dovette attendere la promulgazione della lex Fannia per contenere gli sprechi “culinari” che continuavano a diffondersi.
Quesa legge stabiliva che in ogni banchetto non si potessero spendere più di 120 assi per ogni commensale. Ma, come spesso accade, questa legge rimase solo sulla carta.
Nel Medioevo i legumi presero la scena della tradizione culinaria napoletana. Il re Carlo II d’Angiò possedeva un vero e proprio ricettario nel quale iniziano a vedersi le influenze della cucina spagnola, francese, araba e di altre regioni italiane.
Ma la profonda trasformazione della cucina napoletana si ebbe con l’arrivo dall’America dei pomodori, delle patate, delle melanzane, dei peperoni, dei fagioli, del cacao.
Questi nuovi ingredienti, con i loro caratteristici aromi, modificarono radicalmente la caratteristica dominante agrodolce che aveva contraddistinto, fino ad allora, la cucina all’ombra del Vesuvio.
Nel ’500 avviene la rivoluzione che cambierà per sempre il mondo della cucina: la pasta.
Sappiamo che la pasta non è nata a Napoli, ma certo qui è stata portata alla perfezione e, per la precisione a Gragnano dove, a soli pochi chilometri dal capoluogo, nacquero i primi pastifici a conduzione familiare che trovarono il modo di essiccarla e conservarla.
La creazione delle varie “trafile” (perciatelli, ziti, paccheri, fusilli, spaghetti, vermicelli e le linguine) spinse a ricercare diversi tipi di salse che si adattassero a queste.
La creatività napoletana iniziò a spaziare dalla classica salsa di “pummarola” (nella quale trovarono posto gli antichi olio d’oliva, aglio e basilico) al semplicissimo “aglio e uoglio”, fino a tutta la rassegna dei sughi accompagnati da verdure o da frutti di mare, fino all’apoteosi del ragù.
Verso la fine del ‘700 Napoli divenne luogo di confronto delle grandi cucine europee.
Quando nel 1768 Maria Carolina d’Asburgo giunse a Napoli come sposa di re Ferdinando IV di Borbone, Napoli divenne dimora di cuochi francesi venuti a dar lezioni di arte culinaria e a prendere servizio presso famiglie altolocate.
Le passioni della regina furono seguite da tutti gli aristocratici napoletani che iniziarono a seguire la moda della famiglia reale.
Nacque così uno straordinario connubio di cucina partenopeo-transalpina, frutto dell’unione di tecniche straniere e prodotti locali.
L’inventiva dei cuochi napoletani, intimamente legati agli ingredienti del sud, diede come risultato una cucina sontuosa fatta di timballi, pasticci, arrotolati di carne, impasti lievitati farciti di ogni ben di Dio.
Tutt’oggi i nomi dei piatti sono la dimostrazione dei frutti dell’unione tra gastronomia francese e cucina napoletana. Nomi ispirati dalla lingua francese assumono i suoni dell’idioma locale e diventano il gattò, il culì, il ragù, i potaggi e il purè.
Nel 1773 venne pubblicato a Napoli per la prima volta il trattato di cucina “Il cuoco galante” di Vincenzo Corrado.
I cuochi di casata assunsero il titolo di “monsù”, storpiatura di monsieur. Un titolo di tutto rispetto dato a chi comandava nelle cucine di palazzo.
Il monsù, riverito, ben retribuito e a capo di tutto il personale di cucina, reggeva la “reputazione gastronomica” della famiglia aristocratica che lo aveva al proprio servizio.
Al titolo di monsù seguiva il nome di battesimo accompagnato dal nome della famiglia aristocratica in cui prestava servizio: troviamo quindi monsù Pietro di Cammarata o monsù Alfonso di Sirignano per citarne alcuni di famosi.
Il monsù non solo riproduceva ricette ma creava, dava libero sfogo all’inventiva per stupire gli ospiti, elaborando le materie prime delle dispense di palazzo.
Nacquero così dinastie di monsù che, per asse ereditaria, tramandavano di padre in figlio l’arte culinaria e il “rango”.
Per quanto riguarda la produzione dei vini ci viene in aiuto una lettera di Sante Lancerio (vissuto nel XVI secolo) scritta al cardinale Guido Ascanio Sforza, nella quale cita il «Greco di Somma», il «Greco di Posilico», il «Greco d’Ischia», il «Greco di Torre», «Il vino di Salerno», il «Vino Santo di San Severino» e il «Vino Aglianico».
È descritta una ricca produzione che testimonia la fertilità di questa terra e la capacità vinicola dei suoi abitanti.
Il Lancerio, parlando del «Vino di Fistigno» scrive: «È rosso e viene dal Regno di Napoli, da un luogo sopra la montagna di Somma. Tale vino si domanda Fistignano rispetto alla sorte o viticcio dell’uva. In questo luogo sono vigne erborate et uva assai rossa e dolce, e fa il vino maturo e dolce e carico di colore.»
E conclude scrivendo che «Il meglio vino che si faccia è della possessione di Mons. Domenico Terracina, ma raro viene a Roma, perché i Viceré lo vogliono per loro, e certo è buona bevanda».
Ancora oggi nella cucina napoletana ritroviamo gli stessi piatti e gli stessi rituali antichi.
Immancabile il rito del pranzo domenicale in famiglia che inizia già al mattino presto quando nella casa e giù, fra strade e vicoli, si diffonde nell’aria l’odore del ragù misto all’aroma del caffè.
Un pranzo, quello domenicale, che inizia con l’immancabile ragù che deve aver pippiato per almeno cinque ore, e finisce con il dolce.
Perché Napoli ha un dolce per ogni ricorrenza. La rituale “guantiera” di paste la domenica; la pastiera a Pasqua, di buon auspicio per il raccolto; gli struffoli e i rococò a Natale; il migliaccio a carnevale; le zeppole di San Giuseppe ovviamente nel giorno dedicato al Santo.
Un dolce per ogni celebrazione, per ogni situazione, come le sfogliatelle o come il babà dolce che rientra nella categoria dei dolci alla moda parigina, da portare in dono all’ospite.
E cosa offrire agli ospiti a fine pasto? Il rosolio!
Deriva il suo nome dal latino “ros solis”, cioè rugiada di sole, e dal greco “drosera” e “rosolida”, col significato di coperto di rugiada.
È un “liquore preparato con alcol, zucchero e acqua nella stessa proporzione, con in più un’essenza che gli dà nome”: quindi, rosolio alla rosa, rosolio alla menta …
Ha radici che risalgono a fine Seicento e nasce nei conventi, con le suore che lasciavano macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso e delicato, da offrire agli ospiti.
Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni.
Le piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto sono molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa.
E le donne napoletane, ma anche gli uomini, danno libero sfogo alla inventiva … alla fantasia … ed ecco nascere ‘o Nucillo a base di noci cannella e chiodi di garofano; ‘o Limoncello a base di limoni della penisola Sorrentina o della Costiera Amalfitana; ‘a Fravulella; a base di fragole e vaniglia; ‘e lagreme ‘e Vedova a base di chiodi di garofano cannella e noce moscata; ‘o liquore cu ll’ove a base di latte uova freschissime Marsala e vaniglia.
Che dire per concludere? … “Favurite ca ve faccio cunzulà!”
Gennaro Agrillo
fonte
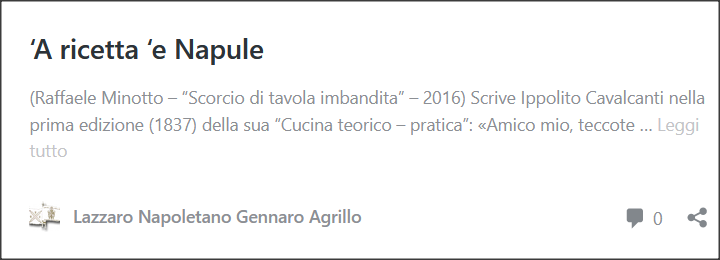
Posted by altaterradilavoro

