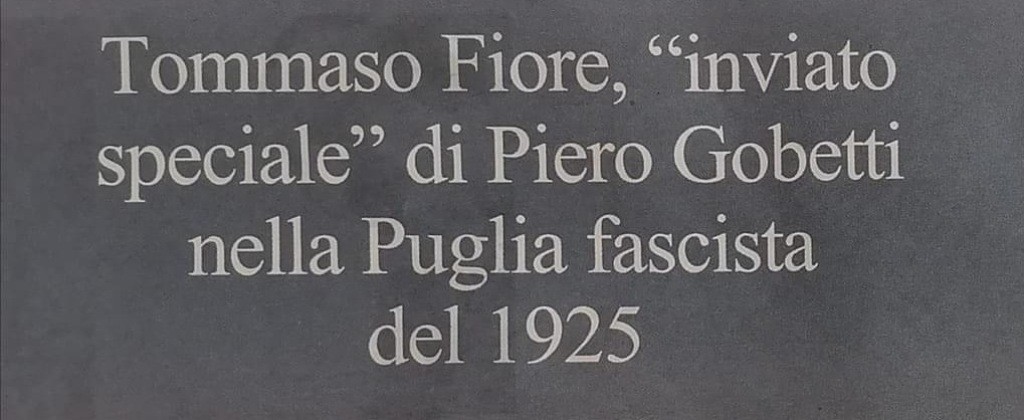TOMMASO FIORE, “INVIATO SPECIALE” DI GOBETTI NELLA PUGLIA FASCISTA DEL 1925*
di Michele Eugenio Di Carlo**
Tommaso Fiore, letterato e politico nato ad Altamura nel 1884, esponente dell’interventismo democratico, prese parte da ufficiale alla Iª Guerra Mondiale. Nel 1920 fu tra i fondatori del Movimento dei Combattenti e fu eletto sindaco di Altamura. Fedele alla linea antigiolittiana di Gaetano Salvemini e aderente alle tesi antiprotezioniste di Antonio De Viti De Marco venne anche eletto nel Consiglio Provinciale di Bari.
Ha collaborato con “L’Unità” di Salvemini, con “La rivoluzione liberale” di Piero Gobetti e con “Il Quarto Stato” di Nenni e Rosselli. A causa della sua intensa attività da azionista, socialista e antifascista, è stato più volte arrestato nei primi anni Quaranta. Sciolto il Partito d’Azione, si è iscritto al Partito Socialista .
L’attività politico-intellettuale di Fiore si può riassumere in una costante azione contro il centralismo statale, maturata durante l’esperienza da sindaco e cresciuta nella certezza che le regioni del Mezzogiorno in un sistema federale sarebbero state protagoniste del proprio destino. Insieme a Salvemini, Fiore combatte il trasformismo politico, che l’amico Guido Dorso riteneva responsabile del fallimento degli ideali risorgimentali e delle condizioni semifeudali del Mezzogiorno.
Il rapporto con Salvemini, sin dal 1912, si era consolidato lungo l’aspra critica al sistema giolittiano che, come scrive Giuliano Minichiello , l’intellettuale di Molfetta aveva riassunto in tre punti: Stato accentratore, oppressione del Nord Italia, mantenimento di un sistema semifeudale al Sud che consentiva al ceto agrario lo sfruttamento del popolo rurale.
Lo stretto rapporto con Dorso, evidente sin dalla sottoscrizione dell’Appello ai meridionali nel 1924, si consolidava con la recensione positiva alla Rivoluzione meridionale nel 1926 , sia per la piena condivisione del concetto di «conquista regia», sia per la linea liberista e anticentralista. Ma anche, in comune con Gobetti, sull’attribuzione al partito di Gramsci di una funzione liberale, particolarmente Mezzogiorno. Una posizione, quest’ultima, che costringeva Carlo Rosselli, nella premessa editoriale alla recensione di Fiore, di muovere una critica al giudizio positivo espresso sul lavoro svolto dai comunisti.
Fiore iniziava a scrivere le «lettere pugliesi» su invito di Piero Gobetti. Infatti, le prime quattro del 1925 erano pubblicate ne «La Rivoluzione liberale», mentre le ultime due del 1926, scomparso l’editore torinese, erano divulgate dalla rivista «Coscienza» dal direttore Giuseppe Gangale. Sconosciute ai lettori a causa della soppressione della libertà di stampa, sono state ripubblicate nel testo Un popolo di formiche dall’editore Laterza nel 1951 , da molti ritenuto uno dei maggiori classici della letteratura del Novecento di Puglia, con la prefazione di Gabriele Pepe.
La prima lettera del 15 gennaio 1925 metteva in evidenza le difficoltà dell’autore nel corrispondere all’invito di Gobetti, considerato il complesso contesto politico-culturale che la Puglia attraversava nei primi anni del fascismo: «[…] tutti pare abbiamo smesso di scrivere, perché non è in nessun modo cosa prudente affidare i propri pensieri alla carta, peggio alla posta», specie in paesi consegnati nelle mani di «pochi facinorosi, due o tre agrari assenteisti, due mazzieri, […]». In questa prima lettera emergeva chiara la matrice trasformista della politica italiana che l’amico Dorso stava tratteggiando puntigliosamente ne La rivoluzione meridionale e che non aveva consentito al Mezzogiorno di affrancarsi da quella che l’intellettuale avellinese definiva «conquista regia» piemontese. Garibaldi aveva appena lasciato alle spalle il Volturno che già «i figli dei delatori borbonici e dei carnefici, scomodati appena un poco i ’60, riottenevano qualche anno dopo cariche e onori». Il fascismo stesso si era concretizzano in virtù dell’ennesima operazione trasformista tra una rivoluzione mancata e gli antichi potentati liberal borghesi, tanto più che a esso avevano aderito, credendo nella «rivoluzione», anche radicali, socialisti e repubblicani.
Era l’occasione per Fiore, guardando ai magici trulli di Alberobello e alle splendide terrazze pietrose coltivate nella Murgia assetata, di elogiare l’antico, il laborioso, l’umile popolo di contadini che era riuscito laddove «un popolo di giganti» si sarebbe arreso e spaventato. Quel «popolo di formiche» a cui lo Stato unitario aveva negato «diritti di vita politica», consegnato alla cupidigia e all’arroganza di un miserabile ceto agrario semifeudale e all’amara emigrazione verso le Americhe, quale univa via di redenzione.
Il riferimento a una necessaria riforma tributaria, citando Giustino Fortunato che nel 1904 aveva scritto La questione meridionale e la riforma tributaria , era d’obbligo. Così come anche la critica al centralismo piemontese: «Qualunque sistema di autocontrollo della vita comunale, e comunque male esercitato per imperizia, per cecità di classi e per corruttela, recherà ai comuni ed a tutta la vita periferica danni infinitamente minori di ogni interventismo dall’alto». Così Fiore si apriva al pensiero ricorrente della sua attività politico-culturale: l’autonomismo locale in un preciso quadro di federalismo richiamante Cattaneo, come si evince chiaramente nell’articolo Ritorniamo a Cattaneo . Sempre, come riferisce Giuseppe Giacovazzo nella prefazione dell’edizione della Nuova Palomar, superando la «polemica astiosa tra Nord e sud», senza «mai livore né accanimento, semplicemente con tanta passione e «veleni mai» .
La seconda lettera a Gobetti dell’aprile 1925 risultava un resoconto del suo viaggio da «inviato speciale» nella terra dei trulli e della Murgia. Coglieva l’occasione per riproporre l’antica questione demaniale, irrisolta per la famelicità degli «abbienti» agrari assenteisti che, «perfettamente evirati, neutrali», chiunque fosse al governo, rivendicavano semplicemente il diritto di dedicarsi all’unica attività di cui erano capaci: la «libertà di giocare a carte e di ridere innocentemente dei borghesi paesani». L’ovvia deduzione era che non occorreva confondere «l’impermeabilità meridionale al fascismo» con una «attiva volontà antifascista»: i «signori» dei paesi non erano cambiati, erano gli stessi che avevano bussato alla porta di Salandra, trovando poi «nel nazionalismo e più nel fascismo uno scudo più saldo» al fine di tutelare i propri untuosi interessi, sempre avversando le sacrosante pretese del popolo rurale. Anche i contadini erano rimasti quelli di sempre, servi della gleba per volontà e responsabilità condivise dai governi unitari, alla ricerca perenne di un pezzo di terra «contro i loro padroni, proprietari assenteisti o grandi affittuari sfruttatori», protetti dallo Stato in cambio della fedeltà al governo centralista e antimeridionale.
E se mentre i Borbone, nella seconda metà del Settecento, avevano tentato di risolvere la questione demaniale, poi perdendo «la testa per le novelle di Francia» e facendo impiccare persino il ventenne di Minervino Murge Emanuele De Deo, Fiore si chiedeva: «che cosa ha impedito al nostro governo di far qualcosa dopo l’inchiesta Jacini e dopo l’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini del Mezzogiorno?».
La risposta la trovava in Giustino fortunato, leggendo il testo sulla questione demaniale pubblicato nel 1879 . L’intellettuale lucano, come tra gli altri Franchetti e Salandra, si era convinto che la competenza nella ripartizione delle restanti terre pubbliche e nelle reintegre delle terre usurpate doveva passare dai comuni allo Stato, dato che le quote tornavano al Comune o venivano svendute ai proprietari terrieri o cedute agli usurai a causa di debiti accumulati. Secondo Fortunato, le quotizzazioni avevano agevolato nell’Italia meridionale «il monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari», accrescendo giorno dopo giorno le «grandi proprietà a danno delle piccole» . Il rionerese lamentava inoltre l’indifferenza del Ministero dell’Agricoltura, nonostante il fallimento delle quotizzazioni demaniali in quel 1879 veniva certificato da pubblicazioni ufficiali .
In Fiore, contrariamente a Fortunato, era ferma la convinzione che dal 1863 col Regno d’Italia, senza esagerazione, «l’abbandono e l’oppressione» era aumentata, dato che al Grande Brigantaggio si erano aggiunte ininterrottamente altre rivolte popolari. In definitiva, «l’oppressione borbonica» era stata «meno esiziale». Quella borghesia illuministica che tanto aveva brillato nella seconda metà del Settecento, «ricca di cultura e di coraggio civile», e che aveva affrontato galera e esilio dei Borbone, dopo il 1860 risultava «sviata, corrotta, depauperata, spezzata, distrutta dall’unitarismo monarchico e conseguente centralismo statale».
Rivolte popolari represse con la violenza, che l’accademico Napoleone Colajanni, dopo l’intervento armato contro i fasci siciliani del 1892-93, aveva descritto in un testo , denunciando le vere cause sociali del conflitto e individuando le responsabilità nel penalizzante centralismo piemontese, lo stesso contro cui Fiore continuava a lottare. Sulle masse popolari pesavano gravemente i carichi della svolta protezionista, della pressione fiscale, del carovita, delle limitazioni doganali al commercio con l’estero dei prodotti agricoli. Già qualche anno prima, il siciliano aveva spiegato che «l’odio delle classi lavoratrici» era frutto di una immutata prepotenza feudale, che continuava a manifestarsi «sotto l’egida delle autorità governative – prefetti, delegati, carabinieri» . Un quadro che Fiore, girando la Puglia del 1925, aveva trovato peggiorato dall’avvento del fascismo.
Anche lo storico socialista Ettore Ciccotti, convalidando le idee di Fiore, aveva sostenuto che «il governo non si era preso cura di intervenire in sostegno del Mezzogiorno» e sulle condizioni di fine Ottocento aveva scritto nel 1898 Mezzogiorno e Settentrione d’Italia , ritenendo che i conflitti sociali erano risolvibili solo con la contrapposizione frontale al capitalismo, dato che un secolo di dibattiti non avevano risolto la divisione dei demani e dei latifondi, costringendo milioni di contadini «a cercare scampo e sussistenza, con l’emigrazione, oltre l’Oceano» . Il Mezzogiorno, dalla «conquista regia» in poi, era stato costretto a sopportare «imposte crescenti, la vendita dei beni ecclesiastici, l’ampliarsi del debito pubblico», oltre a un «un vero drenaggio di capitale» , mentre la proprietà fondiaria si era andata gravando «di un esorbitante debito ipotecario paralizzata nel presente» e «compromessa per un lungo avvenire» . Dal 1861, il ceto politico dominante era riuscito ad impedire che le «classi popolari del Mezzogiorno s’avviassero a partecipare in qualche modo alla vita civile del loro paese».
La questione meridionale era stata affrontata da studiosi e intellettuali mai andando «alla radice del male» e lo storico lucano finiva per affidare alla nuova generazione di Fiore, Dorso, Rossi-Doria l’impegno di condurre il socialismo a lottare contro le forze capitalistiche.
* Pubblicato sul quotidiano L’Attacco, 31.08.2022, pp. 24-25.
** promotore rete culturale Carta di Venosa